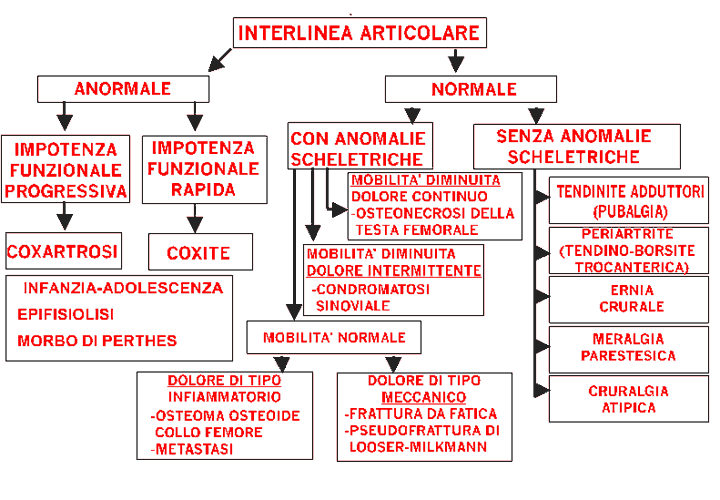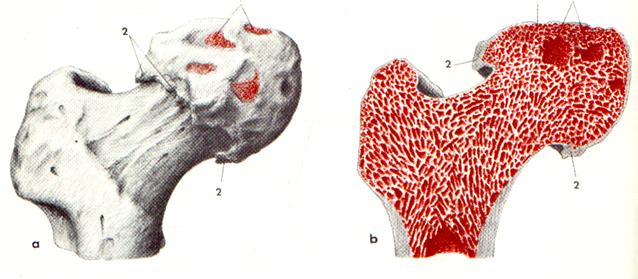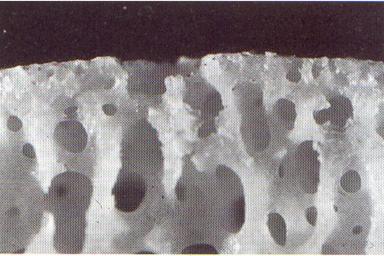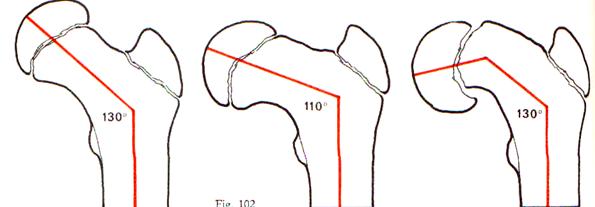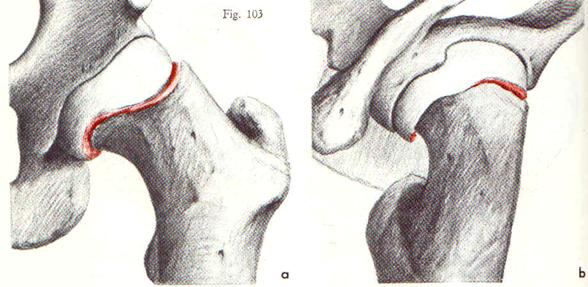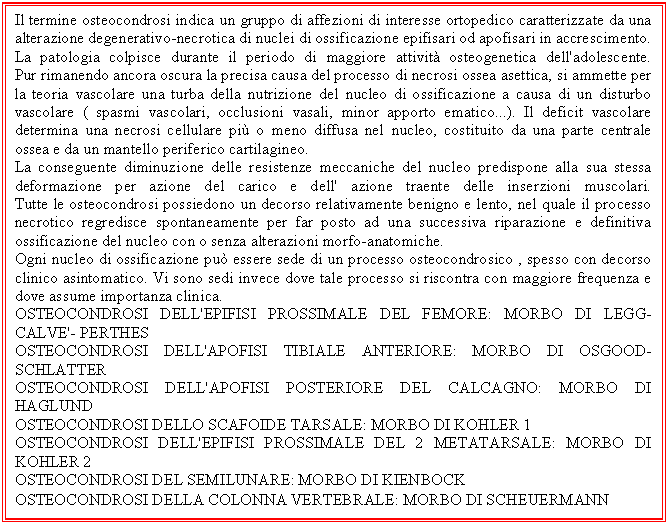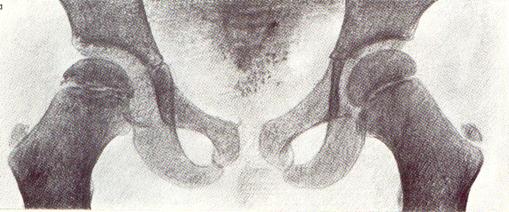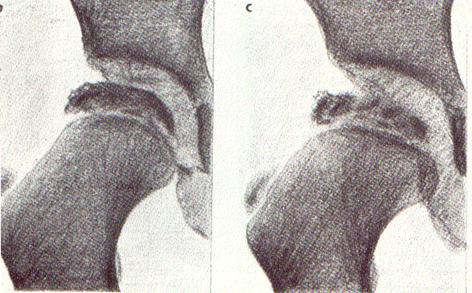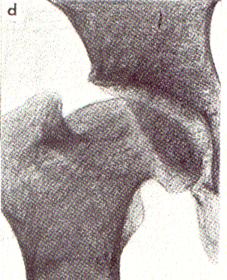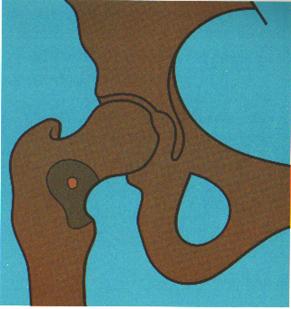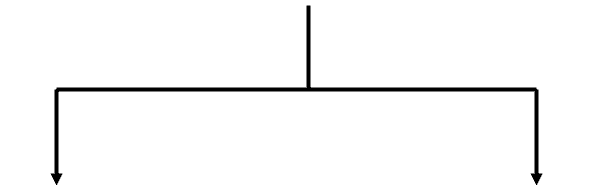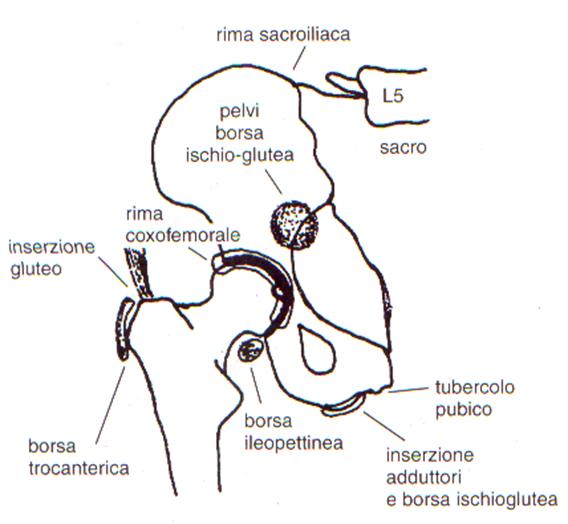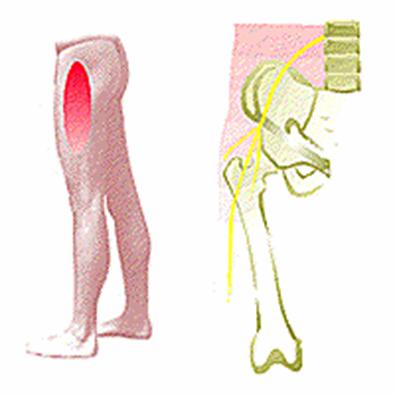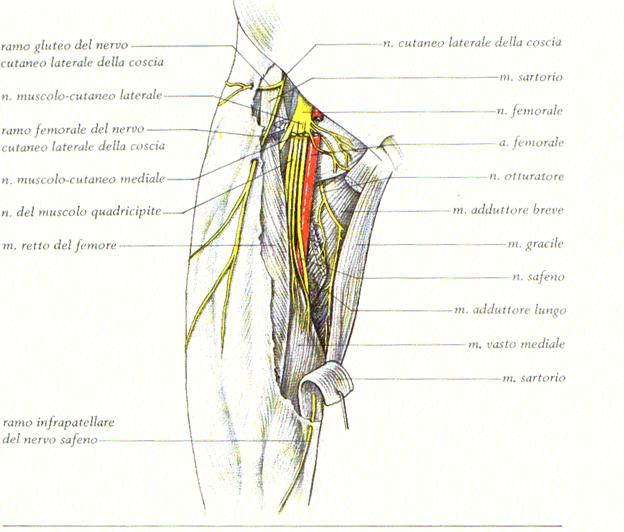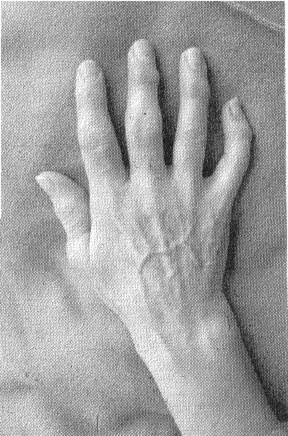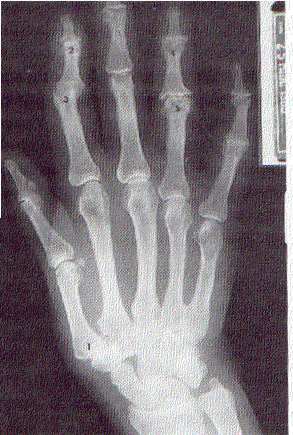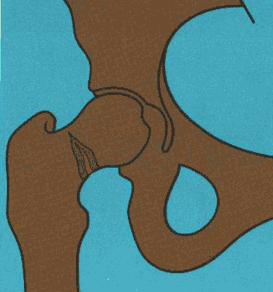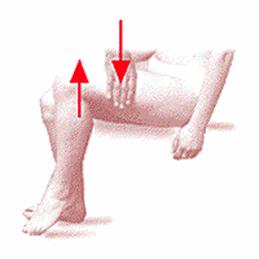DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE DELLE COXALGIE |
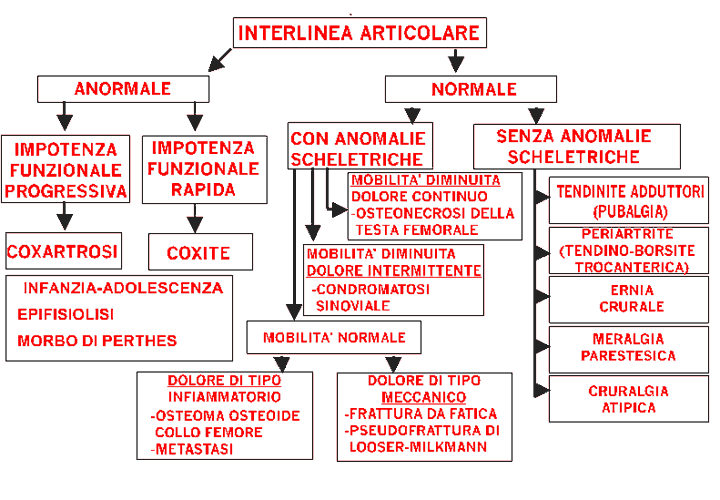 |
Coxartrosi
La coxartrosi può essere la forma di artrosi maggiormente
invalidante e dolorosa.
La posizione ortostatica e la deambulazione sono spesso causa di coxalgia,
che può irradiarsi al versante mediale della coscia e del ginocchio.
L’articolarità è sempre molto limitata, determinandosi
una rigidità dell’anca in flessione, adduzione e rotazione
esterna (posizione “acamatica”).
|
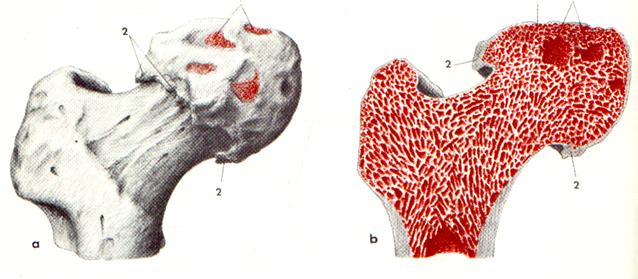 |
Le alterazioni istopatologiche sono quelle dell’artrosi geodi,
osteosclerosi subcondrale, osteofitosi |
| |
 |
| |
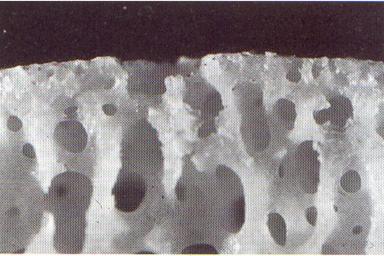 |
| |
 |
| |
Eziopatogenesi dell’artrosi
- MALFORMAZIONI O MALPOSIZIONI ARTICOLARI
Coxa valga o vara, ginocchio varo o valgo
- INSTABILITA’ ARTICOLARE
Iperlassità ligamentosa da trauma o da altre cause (sesso femminile,
malattie del connettivo etc…)
- OBESITA’
In gioco anche fattori endocrini e/o metabolici
- ATTIVITA’ PROFESSIONALI E SPORTIVE
Associate a
TRAUMI E MICROTRAUMI
|
| |
 |
| |
- ETA’
Anche se bisogna osservare che le modificazioni prodotte dall’invecchiamento
sono spesso diverse e di segno opposto rispetto a quelle dell’osteoartrosi
*
- EREDITARIETA’
Trasmissione familiare dell’artrosi alle mani con noduli di Heberden
(HLA A1 e B8)
- INFIAMMAZIONE
Artriti
Processi flogistici in articolazioni artrosiche
|
| |
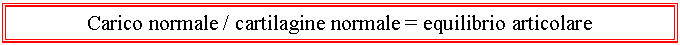 |
| |
*Nella cartilagine senile sono diminuiti:
- il contenuto di acqua
- il rapporto condroitin-4-solfato / condroitin-6-solfato
- l’estraibilità e le dimensioni dei monomeri di proteoglicani
e la rapidità di maturazione dei siti di legame con l’acido
ialuronico.
Questi parametri sono spesso aumentati nell’artrosi.
|
| |
Classificazione |
|
|
Epifisiolisi dell’anca (o coxa vara dell’adolescenza)
Consiste in uno scivolamento, solitamente in direzione posteriore ed
inferiore, dell'epifisi prossimale del femore, causato, nell'adolescente,
da un indebolimento strutturale della cartilagine di accrescimento. |
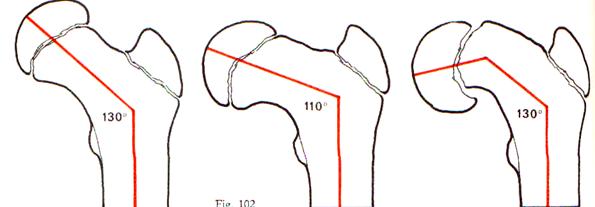 |
| Angolo cervicodiafisario normale |
coxa vara |
epifisiolisi |
|
| |
Fattori predisponenti:
- disturbi metabolici o endocrini, come la sindrome adiposo-genitale;
- uno sviluppo somatico molto rapido;
- l'età: colpisce tra i 10 - 16 anni, e cioè il periodo
del rapido accrescimento scheletrico con una incidenza particolare verso
l'11 anno di vita;
- il sesso: maggiormente colpito risulta essere quello maschile (58%);
- il lato: l'anca di sinistra risulta essere la più colpita rispetto
alla controlaterale, mentre solo nel 25% dei casi si ha un interessamento
bilaterale.
Eziopatogenesi
Il fenomeno riconosce come primo evento una sofferenza della cartilagine
di coniugazione.
E' giusto considerare l'epifisiolisi come una manifestazione a molteplice
eziologia, ma il fatto di riscontrare molto frequentemente tale patologia
in adolescenti affetti da obesità e da ipogonadismo, in soggetti
a rapida crescita con statura e peso corporeo superiore all'età
corrispondente, sembra avvalorare, da una parte, l'influenza del fattore
prettamente meccanico di sovraccarico e, dall'altro, quello endocrino
specie di tipo gonadico; non è un caso, infatti, che in letteratura
non sia mai stato descritto un solo caso di epifisiolisi in ragazze dopo
la prima mestruazione. Alcuni ritengono che anche una anomalia vascolare
locale, nella fattispecie ora una lesione dell'arteria del legamento rotondo,
ora una probabile stasi metatraumatica dei tessuti molli circostanti,
ora una dilatazione delle anse vascolari a livello della zona epifisaria-metafisaria
possa considerarsi come causa scatenante.
Una teoria riconosce nel trauma, non come unico ed isolato su di una cartilagine
normale, ma inteso come una serie di microtraumatismi che si ripercuotono
su di una cartilagine con problemi di resistenza meccanica, una delle
cause della patologia in questione. In pratica l'epifisiolisi del femore
riconosce due eventi fondamentali:
1) la diminuzione di resistenza della cartilagine di coniugazione
2) l'intervento di fattori statici e dinamici (traumi compresi) che determinano
la dislocazione della epifisi femorale, proprio per la particolare conformazione
anatomica dell'articolazione stessa.
|
| |
Anatomia patologica
La testa femorale slitta posteriormente ed in basso, il
collo risale in alto e ruota in avanti.
L'esito di questa migrazione è una deformazione in varismo del
collo femorale, una rotazione esterna e adduzione del femore. |
| |
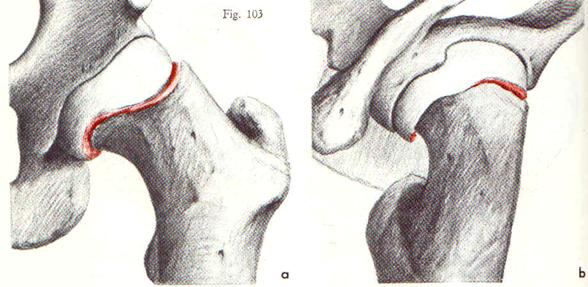 |
Lo scivolamento può essere acuto, ma più frequentemente
la patologia è subacuta o cronica per cui lo scivolamento è
progressivo ed insidioso e si manifesta chiaramente con un episodio acuto
traumatico, anche di lieve entità.
Quando lo scivolamento progredisce lentamente, la testa ed il collo femorale
si deformano lentamente; il periostio viene stirato e in fase di guarigione
la testa diventa smussa con una colata ossea postero-inferiore; al termine
dell'accrescimento la cartilagine di accrescimento si ossifica e si ha
la stabilizzazione della deformità.
La naturale evoluzione dopo la guarigione spontanea porta verso l'artrosi
dell'anca.
Clinica
Dal punto di vista clinico e radiografico si distinguono uno stadio iniziale,
detto di pre-epifisiolisi, ed un secondo di scivolamento vero e proprio.
Nella prima fase di pre-epifisiolisi la sintomatologia clinica non è
sempre costante: il paziente accusa un dolore sordo all'anca, a volte
irradiato verso il ginocchio, mostra una modesta claudicatio alla deambulazione;
i sintomi peggiorano con gli sforzi fisici e spariscono del tutto con
il riposo. Alcune volte si può riscontrare una lieve limitazione
dell'abduzione e dell'intrarotazione dell'anca. Dallo stato di pre-epifisiolisi
si può passare alla epifisiolisi conclamata che può evolvere
in modo acuto o cronico.
L'epifisiolisi cronica è l'evenienza che si presenta più
frequentemente: la zoppia tende ad aggravarsi, il dolore all'anca a non
scomparire solo con il semplice riposo e l'arto viene atteggiato in adduzione
ed extrarotazione. L'arto può risultare accorciato di 1 o 2 cm
e la muscolatura della coscia presenta diminuzione del trofismo e del
tono muscolare.
Nell'epifisiolisi acuta, evenienza più rara, il quadro clinico
si instaura improvvisamente: la causa è da ricercarsi un un traumatismo
che interessa il collo femorale già displasico. Dolore improvviso
e totale impotenza funzionale caratterizzano la sintomatologia clinica.
|
| |
Radiologia
Dal punto di vista radiologico, alcuni casi sono veramente evidenti
|
| |
 |
Questa Ŕ una epifisiolisi monolaterale. |
|
| |
 |
| |
Questa epifisiolisi è bilaterale.
Nei casi meno evidenti è indispensabile una proiezione assiale. |
| |
|
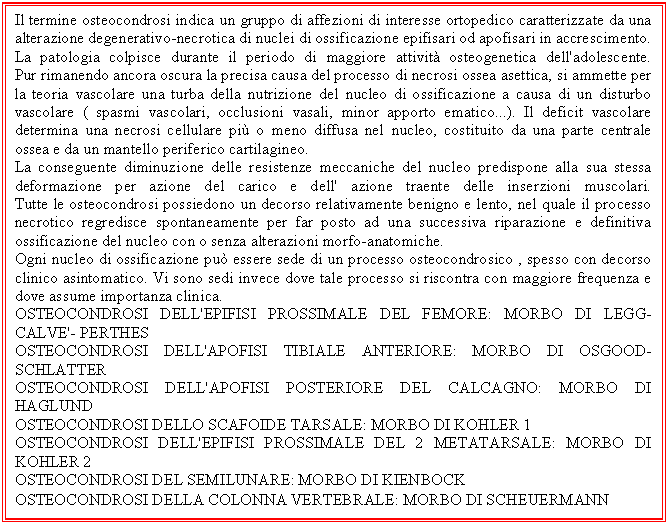 |
| |
Osteocondrosi dell'epifisi prossimale del femore
(morbo di Legg-Calve'-Perthes) |
| |
La malattia si manifesta fra i 3 ed i 12 anni (età media 7
anni) con maggior frequenza nei maschi rispetto alle femmine. La localizzazione
bilaterale è presente nel 10-15% ed in questo caso la manifestazione
clinica compare in un'anca circa un anno più precocemente che nella
controlaterale.
La necrosi più o meno diffusa del nucleo di ossificazione cefalico
del femore è secondaria all'interruzione della vascolarizzazione
nel territorio dell'arteria cinconflessa posteriore. Il risultato dell'ischemia
è un ciclo "naturale" e costante per tutte le forme di
osteocondrosi, composto da cinque fasi successive che conducono a guarigione
spontanea anche se non viene effettuato alcun trattamento.
FASE DEGENERATIVA
In cui si ha l’arresto dell’accrescimento, immediatamente
dopo l’ischemia della testa femorale.
Rigonfiamento ed edema della cartilagine articolare (rx: allargamento
della rima articolare; aumento di spessore e dentellatura della cartilagine
di coniugazione); lieve deformazione del nucleo epifisario. In questa
fase dove le alterazioni radiologiche possono essere molto sfumate, la
RMN è l’indagina più sicura. |
| |
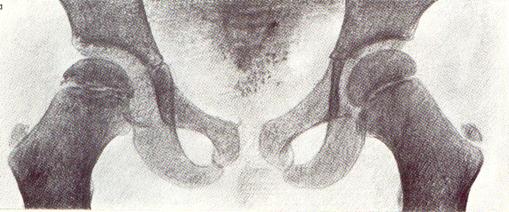 |
| |
FASE DI NECROSI
Frammentazione e necrosi della spongiosa subcondrale (rx: progressivo
schiacciamento ed addensamento del nucleo cefalico, espressione della
necrosi delle trabecole e del loro stipamento reciproco sotto l’azione
del carico; quindi frammentazione del nucleo con alternanza di zone più
radiotrasparenti e zone più radiopache, “aspetto tigrato”. |
| |
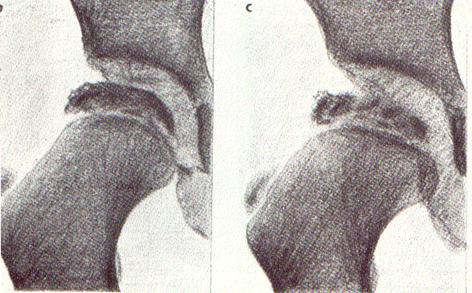 |
| |
FASE DI RIASSORBIMENTO
L'osso necrotico viene lentamente riassorbito; la neoformazione di capillari
determina la ripresa dell'ossificazione encondrale epifisaria. L'osso
neoformato si deposita su quello avascolare con netto aumento della massa
ossea per unità di superficie ( incremento della densità
ossea evidenziabile radiograficamente). |
| |
FASE DI RIOSSIFICAZIONE
FASE DI RIMODELLAMENTO
La testa femorale può venir modellata con aspetto sferico normale
oppure alterato (con coxa magna o plana) ; la eccentrazione o la sublussazione
della testa favorisce una coxartrosi secondaria. Inoltre l'alterazione
della regione metafisaria causa l'accorciamento del collo femorale (coxa
vara). |
| |
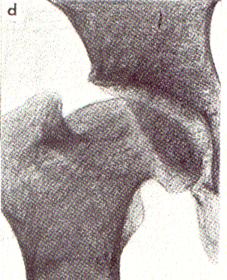
coxa plana |
| |
Nella fase iniziale le manifestazioni cliniche possono essere sfumate
con modica algia intermittente sul versante anteromediale della coscia
e con gonalgia sotto sforzo; successivamente si evidenzia una zoppia di
fuga , una contrattura muscolare antalgica ed una ipotrofia della muscolatura
della coscia e della natica
All'esame obiettivo è caratteristica la retrazione dei muscoli
adduttori della coscia ed una limitazione funzionale dell'abduzione e
della rotazione interna dell'articolazione colpita.
Le ricerche bioumorali sono negative ad eccezione della velocità
di sedimentazione degli eritrociti, che può essere leggermente
aumentata.
Il decorso della malattia della durata è in media di 18-24 mesi. |
| |
|
Osteoma osteoide
E' un tumore benigno, caratteristico per la sua forma, per le sue dimensioni
e per la sintomatologia dolorosa. E' costituito da un tessuto osteoide
circondato da osso sclerotico che ne limita la sua estensione. Ha un decorso
lentissimo e pare che possa anche spontaneamente regredire e guarire.
E' relativamente frequente, specie nel sesso maschile (2/1) e nell'età
che va dai 5 ai 30 anni. Si localizza preferibilmente nelle ossa lunghe
in sede sottocorticale o metafisaria; non eccezionali sono le localizzazioni
alle ossa brevi e alla colonna. La sintomatologia è caratterizzata
dal dolore che insorge senza causa apparente e si acutizza generalmente
durante la notte. Non sempre il paziente è in grado di localizzare
esattamente la sede del dolore che spesso riferisce alla articolazione
più vicina. E' caratteristica costante del dolore da osteoma osteoide,
la scomparsa dopo assunzione di aspirina.
Nelle forme sottocorticali si può apprezzare una tumefazione dovuta
alla reazione periostale, a volte intensa. |
| |
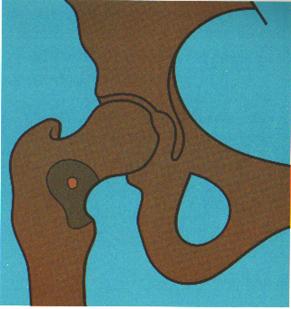 |
| |
L'esame radiografico è caratterizzato dalla presenza di una
piccola area di radiotrasparenza, rotondeggiante od ovale, detta "nidus"
le cui dimensioni non superano cm 1-1,5 circondata da osso sclerotico;
all'interno del nidus si può trovare un nucleo di radiopacità.
Nella zona sottocorticale il tessuto sclerotico può essere molto
abbondante.
Istologicamente il nidus è costituito da tessuto osteoide, organizzato
in trabecole disposte irregolarmente, immerse in un tessuto ricco di cellule
con osteoblasti, osteoclasti e fibroblasti. Il tessuto osteoide è
più maturo al centro, dove si osservano zone calcificate.
La diagnosi è generalmente clinica, per le caratteristiche del
dolore.
L'esame radiografico conferma la diagnosi ed offre il dubbio diagnostico
differenziale con l'ascesso di Brodie e con l'osteomielite cronica sclerosante.
La diagnosi istologica viene a volte confusa con l'osteoblastoma. La terapia
è esclusivamente chirurgica e consiste nella asportazione del nidus.
La recidiva è possibile soltanto quando l'asportazione non sia
stata completa. |
| |
 |
| |
 |
| |
|
FRATTURE SENZA UN TRAUMA SIGNIFICATIVO |
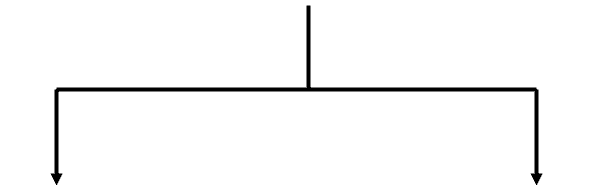 |
 |
OSSO ANORMALE
FRATTURE
PATOLOGICHE DA:
- Tumori benigni e maligni
- Infezioni
- Paget |
OSSO NORMALE
- SUFFICIENTE: FRATTURE DA STRESS
- INSUFFICIENTE: FRATTURE OSTEOPOROTICHE |
|
| |
OSTEOMALACIA
Pseudofratture di
Looser-Milkmann |
|
| |
FRATTURE OSTEOPOROTICHE |
  |
| |
Queste sono una rx ed una RMN di una donna anziana che accusava un
dolore all’anca sinistra.
Le fratture osteoporotiche sono il risultato di un carico normale su un
osso anormale. Spesso ciò accade in individui anziani affetti da
osteoporosi, ma può succedere anche in persone affette da artrite
reumatoide, malattie renali, o in pazienti in cura con corticosteroidi
o irradiati. |
| |
OsteomalaciaÈ
un’osteopatia metabolica caratterizzata da una massa ossea di volume
normale, ma con un ridotto volume minerale, per ridotti livelli sierici
di calcio e di fosfato; corrisponde nell’adulto al rachitismo dell’infanzia. |
| |
 |
Rachitismo ed osteomalacia
nutrizionali
Da ridotta sintesi e/o apporto alimentare di
vitamina D
Osteomalacia da malassorbimento
Da ridotto assorbimento intestinale di vitamina D (morbo celiaco,
gastro-resezione)
Osteomalacia da epatopatia
Da ridotta sintesi di 25-OH-vitamina D (epatopatie croniche, cirrosi)
Osteomalacia da malattie renali
Da ridotta sintesi di 1, 25-OH-vitamina D
(insufficienza renale cronica)
Da perdita renale di calcio e di fosfato
|
Osteomalacia da ipofosfatemia
Ipofosfatemia nutrizionale
Osteomalacia da ridotta responsivitÓ recettoriale
Osteomalacia da ipofosfatasia
Osteomalacia da farmaci
Da difosfonati
Da fluoruri |
|
Sintomatologia
Dolore che si aggrava progressivamente. Astenia muscolare profonda. Deformità
scheletriche. Fratture patologiche.
Radiologia
Decalcificazione generalizzata, pseudofratture di Looser-Milkmann.
|
| |
|
| |
Le pseudofratture sono patognomoniche e differiscono dalle fratture
vere e proprie, anche se possono precederle, per la mancanza del callo
osseo, perché sono spesso incomplete e non vi è spostamento
dei frammenti. |
|
| |
Borsite ileopettinea e tendinite dell’ileopsoas
Borsite trocanterica |
| |
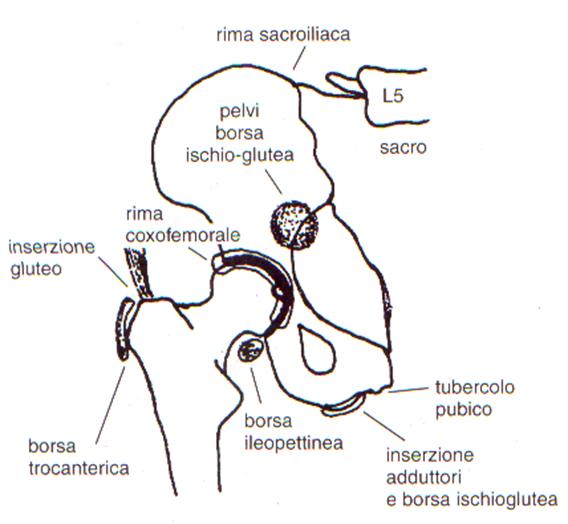 |
| |
La borsa ileopettinea è localizzata nell’inguine al davanti
dell’articolazione dell’anca.
Nella borsite vi è quindi dolore inguinale spontaneo e alla palpazione.
Può associarsi psoite, i cui segni sono dolore alla flessione dell’anca
contro resistenza e attitudine antalgica in flessione. |
| |
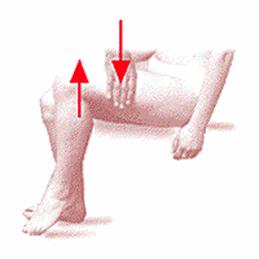 |
|
Il più comune problema extracapsulare dell’anca
è la borsite trocanterica.
La borsite trocanterica rappresenta un’eccezione alla regola
che la rotazione dell’anca è dolorosa solo se vi è
un problema intracapsulare dell’articolazione.
Infatti la rotazione interna, con anca e ginocchio flessi a 90°,
causa dolore vivo per la compressione che i tessuti molli sovrastanti
esercitano sulla borsa.
Nei casi acuti è possibile apprezzare una tumefazione molle,
corrispondente alla borsa edematosa, e comunque vi è dolore
spontaneo e alla palpazione.
|
|
| |
Meralgia parestesica
E’ una condizione dolorosa (nevralgia tronculare)
dovuta ad intrappolamento od aggressione del nervo cutaneo laterale del
femore, nel punto di uscita dalla pelvi. Chi è affetto da meralgia
parestesica si lamenta di un dolore sordo, fastidioso, intorpidente, formicolante
o di una sensazione di bruciore sulla faccia anterolaterale della coscia.
|
| |
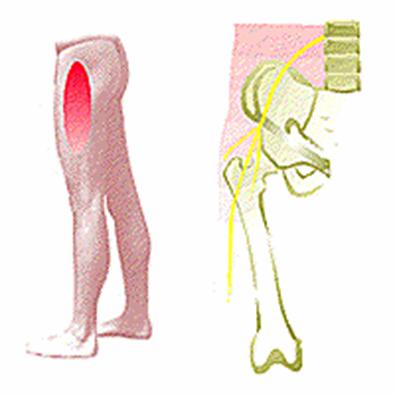 |
| |
Il dolore può avere diversa intensità, da leggero a
molto intenso ed insorge di frequente durante il movimento e si allevia
a riposo. Il nervo cutaneo laterale del femore origina dalla divisione
posteriore di L2 ed L3 ed è solo sensitivo. Dopo l’emergenza
dai fori intervertebrali il nervo attraversa l’addome, prima presentandosi
sul bordo laterale dello psoas, poi attraversando obliquamente il muscolo
iliaco fino alla SIAS. Il nervo poi abbandona la pelvi attraversando le
fibre del legamento inguinale medialmente alla SIAS. Il nervo è
strettamente circondato dalle fibre tendinee del legamento inguinale fa
una curva in senso orario ed abbandona l’andamento orizzontale che
aveva nella pelvi per prendere una direzione più verticale nella
coscia, dove si divide in una branca anteriore ed in una branca posteriore,
che attraversano la fascia lata. Le varie ipotesi patogenetiche sulla
meralgia parestesica si basano sulla stretta relazione anatomica tra il
nervo e le altre strutture della regione inguinale:
1. Il nervo può essere piegato o compresso contro il bordo tagliente
della fascia iliaca quando la perfora prima di uscire dalla pelvi attraverso
il legamento inguinale.
2. Il nervo può essere sottoposto ad attrito quando si incunea
tra l’attacco del legamento inguinale con la SIAS.
3. Il nervo può subire una compressione quando passa attraverso
le fibre tendinee del legamento inguinale.
4. Il nervo può essere compresso quando passa sopra la cresta iliaca
o dal sartorio o dal tensore della fascia lata. |
| |
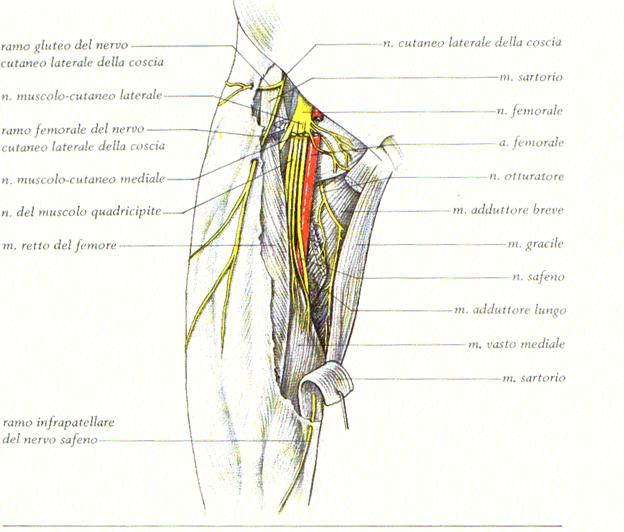 |
| |
Numerosi fattori possono contribuire al danno meccanico sul nervo alla
sua uscita da sotto il legamento inguinale come obesità, vestiti
stretti o busti, pressione diretta sulla coscia nella regione del nervo,
problemi posturali, cicatrici chirurgiche. La meralgia parestesica colpisce
più il sesso maschile e può essere bilaterale in circa il
25% dei casi. Il dolore è aggravato dalla estensione, dallo stare
in piedi o camminare per lunghi periodi, e alleviato dalla flessione.
Vi è nei tre quarti dei casi un punto doloroso sul legamento inguinale,
due dita medialmente alla SIAS. La diagnosi differenziale è con
patologie spinali, retroperitoneali, addominali, pelviche, diabete, ernia
L2-L3 (che provoca un’alterazione del riflesso rotuleo, che non
si verifica nella meralgia parestesica). |
| |
|